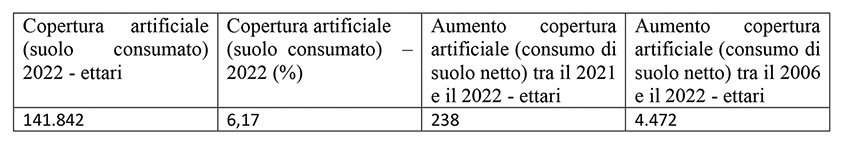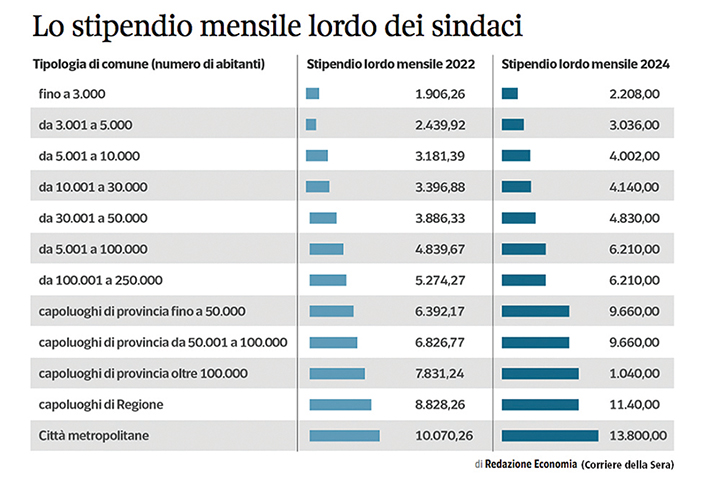di Francesca Corsetti – In ambito di economica circolare, una start up italiana si è recentemente distinta vincendo il Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2023 alla Fiera di Ecomondo, una delle manifestazioni principali per la transizione ecologica: stiamo parlando del progetto CIRTAA, cioè del Centro Internazionale delle Ricerche sul Trattamento e Applicazioni dell’Asbesto, con sede in Sicilia. Grazie all’esperienza e alla ricerca del fondatore e amministratore unico, il casentinese Paolo Tuccitto (nella foto mentre riceve un premio per la sua attività), CIRTAA propone di trasformare l’amianto, noto per la sua pericolosità, in una preziosa materia prima.
Tuccitto, che da anni collabora con l’Università di Siena, l’università Milano Bicocca e l’Università di Catania, è titolare di vari brevetti sui processi per l’inertizzazione dell’amianto, in Italia (UIBM) e all’estero (EPU). Ci siamo rivolti a lui per ottenere informazioni dettagliate sul suo lavoro e sui progetti in corso, esplorando al contempo le sue scoperte innovative.
«CIRTAA si occupa di sviluppare quello che sono le mie invenzioni, è uno strumento con cui le metto a punto. Lo scopo è quello di studiare applicazioni su come può essere utilizzato l’amianto e sull’operazione che possono renderlo inerte; quindi, come prima cosa, dobbiamo occuparci di renderlo non pericoloso, poi ne studiamo le applicazioni. Le applicazioni che io ho brevettato sono le materie prime critiche e strategiche: io riesco a estrarre dall’amianto alcune di queste».
L’amianto, per le sue caratteristiche e i bassi costi di lavorazione, è stato utilizzato nel tempo in numerosi campi e in oltre tremila tipologie di prodotti. «È l’unica roccia che si può tessere, perché ha un aspetto fibroso e gli antichi ne facevano i tessuti. Ad esempio, vi avvolgevano i defunti, e poi lo usavano nella cremazione per separare le ceneri. Oppure veniva usato nei vasi ceramici: molti vasi che sono riusciti ad arrivare ai giorni nostri contengono amianto» che, non a caso, significa “incorruttibile”.
«Un altro esempio è il cemento che è stato usato per la costruzione del Pantheon o del Colosseo, cementi che contenevano amianto, che li ha fatti durare nel tempo. Negli anni si è poi scoperto che era cancerogeno: già agli inizi del Novecento si sapeva che chi lavorava l’amianto aveva vita più breve, ma ci sono voluti decenni per vietarlo». Fu, infatti, la legge numero 257 del 27 marzo 1992 a dettare le norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo smaltimento controllato.
Oggi invece, l’amianto non fa più paura. Continua Tuccitto: «l’amianto è principalmente formato da silicio e magnesio: sono materie prime tra quelle più importanti perché il silicio serve, ad esempio, per produrre i pannelli solari, ma viene utilizzato anche in agricoltura o come integratore. Anche il magnesio viene ricavato da minerali che lo contengono, e principalmente parliamo di amianto. Paradossalmente, è quello che ne contiene più di tutti: viene estratto utilizzando degli impianti termici e può essere quindi utilizzato nell’industria farmaceutica o anche nell’industria bellica , già a inizio del Novecento, essendo altamente infiammabile, il magnesio veniva usato per produrre le bombe incendiarie».
Quindi, una volta inertizzato, dall’amianto si possono produrre le materie prime critiche, ma si può utilizzare semplicemente anche il prodotto della trasformazione: la forsterite, un silicato di magnesio. «Sono stato uno dei primi a determinare la forsterite come biomateriale, o materiale bioinerte. Oggi, a distanza di qualche anno, ci sono sempre più pubblicazioni scientifiche che confermano la mia tesi: cioè, che la forsterite ha caratteristiche di elevata biocompatibilità ed è quindi un materiale che può essere riassorbito dal tessuto osseo e può rigenerarlo. Riesco dunque a produrre forsterite, materiale molto raro in natura, tant’è che è considerato materiale meteoritico, dal processo di inertizzazione dell’amianto che ho brevettato. Questa è stata l’invenzione per cui ho ricevuto il premio di Ecomondo».
Concentrandoci un po’ più sulle sue esperienze personali e professionali, come si è arrivati alla fondazione di CIRTAA? «Prima di questa start up ho avuto altre società che si occupavano sempre di inertizzazione, i primi brevetti risalgono al 2011. Nel 2015 ho creato una società negli Stati Uniti, poi un’altra in Italia, ed ero legato ad altre persone, sempre collaborando con grandi studi, ingegneri e chimici. Però, come succede anche nelle migliori famiglie, non sempre i rapporti sono sereni. Le società sono terminate e nel frattempo io mi sono dedicato ai miei studi, utilizzando la parte termica. Io ho fatto il commercialista per vent’anni, ma avevo come clienti grandi società che si occupano di termovalorizzatori, quindi grandi impianti termici. La mia esperienza è stata fondamentale. Ho utilizzato delle forme particolari di combustione, che sono utilizzate in ambito metallurgico per il trattamento dei metalli per particolari usi industriali, come i metalli preziosi, che devono essere trattati prima di essere venduti. In ambito metallurgico, per l’acciaio viene utilizzata questa particolare categoria di forni, chiamati forni ad atmosfera controllata perché utilizzano delle atmosfere in alta temperatura. Sono rari in Italia, ma molto sviluppati all’estero, e io li ho usati modificando i parametri di gas nelle miscele gassose utilizzate per la combustione e li ho adattati ai minerali, e non più ai metalli. Nel tempo sono riuscito a trovare la formula giusta per poter essere applicata anche negli amianti. Da lì, negli anni, è venuto fuori lo studio su come fare le varie applicazioni. I risultati hanno interesse da grandi gruppi. Un gruppo industriale che voleva fare un impianto con me è la Sei Toscana: nel 2019 avevo un contratto per realizzare un impianto, ma con il Covid è saltato. Sono stato avvicinato dalle acciaierie di Taranto o dall’Interporto di Gala, ma anche da gruppi petroliferi come Eni e altri, di cui non posso fare il nome, anche esteri».
Sappiamo adesso che per questa procedura vengono impiegati i forni ad atmosfera controllata, ma può parlarci meglio del processo che ha brevettato? «Uno dei miei soci costruisce quei forni da cinquant’anni, e sono ad oggi utilizzati nell’ambito metallurgico. Non è il forno che cambia, ma è il come può essere alimentato: le miscele di gas devono essere parametrate per quello che è il funzionamento, ma la tipologia di forno è la stessa. L’impianto non è rappresentato solo dal forno, ma anche da un sistema automatico di gestione. Tutta la movimentazione viene fatta in camere in depressione, che fanno sì che l’attività microbica e fibrotica rimanga confinata all’interno in modo da non contaminare l’esterno. Poi abbiamo un sistema di trattamento aria, una tecnologia finlandese per polarizzare l’aria: questo significa che l’aria non viene filtrata, ma caricata elettricamente e quindi viene catturata come se fosse una calamita. In questo modo siamo sicuri di trattenere tutte le fibre. Infatti, l’amianto ha fibre nanometriche e non esistono filtri che possano trattenere fibre così piccole, non essendoci questa tecnologia, mi avvalgo di un’altra: polarizzo le polveri e le fibre di amianto. Questo è il sistema che ho brevettato e serve per poter svolgere in sicurezza la lavorazione dell’amianto».
Quali sono quindi gli obiettivi futuri del progetto CIRTAA? «L’obiettivo è quello di realizzare un primo impianto sperimentale in collaborazione con università ed enti pubblici; quindi, al momento è molto importante individuare un sito idoneo, in Italia o all’estero. Ad oggi, il valore della materia prima prodotta dall’amianto varia dalle diverse decine di migliaia di euro al chilo. Le applicazioni sono molto ricercate, perché possono essere strategiche, per centrali nucleari, industria della difesa, elettronica, aerospaziale, biomateriali, ma anche per i metalli preziosi, perché la forsterite è un cristallo che si misura in carati (0,2 grammi), il cui valore più arrivare anche a cento euro al grammo. Quindi più che la sperimentazione è importante trovare il partner giusto, ci sono molte proposte che sto valutando, ma non è una scelta facile».