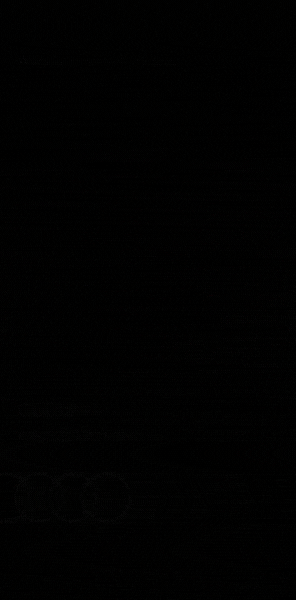di Marco Roselli – Siamo in autunno, tempo di castagne da fare “bruciate” o “ballotte”, come si dice dalle nostre parti, ma gli impieghi di questo fantastico frutto della montagna sono davvero numerosissimi. In questo articolo però vogliamo parlare dello stato sanitario dell’albero, in quanto molti sono i suoi ospiti, non tutti graditi, alcuni di recente introduzione.
Premessa
In Toscana il castagno è ampiamente diffuso, estendendosi dalle aree mediterranee fino alle quote più alte dell’Appennino. Grazie alla possibilità di essere coltivato a ceduo o ad alto fusto, ha costituito per secoli una importante risorsa economica per il mondo rurale e montano. Nonostante la sua vigoria il castagno ha attraversato negli ultimi decenni un periodo di crisi, dovuto all’abbandono della montagna e all’azione di gravi patologie, che hanno determinato una notevole riduzione delle superfici coltivate.
Castagne e marroni
Al contrario di quanto comunemente si pensa, non è una questione di misure. La distinzione commerciale delle varietà di castagno in marroni e castagne comuni poggia le sue basi sulle caratteristiche tecnologiche e gustative dei frutti, e non sulle dimensioni degli stessi.
Le varietà di marrone possiedono i seguenti requisiti:
– buccia di colore mogano chiaro con striature di colore scuro che corrispondono a rilievi della buccia avvertibili al tatto;
– frutto di forma ovale-allargata;
– buccia sottile che ricopre una pellicola non penetrante nella polpa del seme e di facile asportazione;
– polpa zuccherina e croccante che mantiene la consistenza in seguito a una prolungata cottura;
– assente o ridotta cavità all’interno della polpa dei frutti;
– bassa percentuale di frutti divisi dalla pellicola interna.
I frutti che presentano le caratteristiche del marrone meglio si adattano a essere sottoposti a qualunque lavorazione della filiera del castagno, in particolare al processo di canditura e glassatura.
Malattie vecchie e nuove
Cinipide del castagno: Dryocosmus kuriphilus
Piccolo insetto dell’ordine degli imenotteri, particolarmente dannoso per il castagno, è arrivato in Italia dalla Cina. La prima segnalazione nel nostro Paese è avvenuta nel 2002 in provincia di Cuneo e, a partire dal 2008, anche in Toscana. I danni si concretizzano con la formazione di galle fogliari che riducono lo sviluppo dei germogli e quindi la produzione.
In alcune annate le perdite possono arrivare fino al 60-70% anche se le stime sono difficili, quando si hanno primavere molto siccitose.
Un esempio di lotta biologica di successo
Fortunatamente dopo un primo periodo di insediamento nel quale l’insetto ha compiuto i danni maggiori, è stato introdotto il suo nemico naturale, l’imenottero “Torymus sinensis”, il quale vive a spese dell’ospite dannoso parassitizzandolo (la larva del Torimus si nutre dell’altra).
La situazione ad oggi
I lanci del parassitoide effettuati dagli enti pubblici e dalle associazioni private hanno portato ad un sensibile miglioramento della vegetazione. Segno evidente che l’insetto amico si sta riproducendo a spese di quello dannoso in modo efficace. Da considerare che l’introduzione artificiale del Torimus sinensis, ha comportato dei problemi a causa della mortalità dovuta alla logistica e ai trasporti.
Il consiglio del tecnico di campagna
Esperienze di lotta biologica di successo sono state effettuate dai servizi di sviluppo agricolo fin dai primi anni novanta in provincia di Arezzo.
Casi documentati sono, ad esempio, il controllo del ragnetto rosso dei fruttiferi (Panonycus ulmi) con l’introduzione degli acari fitoseidi (Phytoseiulus persimilis), azione che ha consentito di ridurre il numero di trattamenti fitosanitari specifici del 90%. Altre esperienze sono state fatte con il lancio degli insetti utili allevati nelle biofabbriche per eliminare afidi o acari dannosi alle colture orticole. Secondo la mia esperienza la lotta biologica è uno strumento validissimo che però necessita di continuità. Predatori e parassitoidi impiegano anni per insediarsi quindi, le azioni di introduzione e valorizzazione, anche dei soggetti selvatici, debbono essere mantenute nel tempo. Diversamente, chi si nutre di foglie, presto o tardi torna a prendere il sopravvento su chi deve cacciare.
Cancro della corteccia
La malattia è causata dal fungo ascomicete “Cryphonectria parasitica”. L’agente patogeno è giunto in Europa negli anni trenta dal nord America tramite materiale infetto e ha causato, nel recente passato, danni tali da far temere per la sopravvivenza del castagno nel nostro ambiente. Il parassita penetra nella corteccia dei rami e dei giovani fusti attraverso ferite e provoca cancri che possono estendersi fino a circondarli completamente. La corteccia degli organi colpiti assume una colorazione scura, appare depressa con profonde fessurazioni e, sollevandola, si osservano i caratteristici “ventagli” di color bianco-crema, costituiti dal micelio parassita.
Dopo la fase iniziale di forte espansione e di grave mortalità, la virulenza della malattia è lentamente regredita permettendo la ripresa dei castagneti. Ceppi di “C. parasitica” sono risultati contaminati da una particella virale (ds-RNA presente nel citoplasma del micelio) che ne ha attenuato la virulenza. Il fenomeno del l’ipovirulenza, studiato inizialmente in Italia ed in Francia, riguarda pressoché tutti i castagneti della penisola. In sostanza la malattia si è ammalata con il risultato che è diventata meno aggressiva per la pianta.
I ceppi ipo-virulenti sono caratterizzati da una minore aggressività: il loro micelio non uccide il cambio, a differenza di quanto accadde in caso di infezione da ceppi virulenti, permettendo ai tessuti della pianta di reagire con la produzione di calli e barriere di sughero. Inoltre l’insediamento del ceppo meno aggressivo toglie spazio a quello dannoso, in una logica di competizione. Ad oggi sul territorio toscano è stato rilevato che l’ipovirulenza è predominante pur mantenendosi la presenza degli isolati più aggressivi.
Tipologie di cancri
Come abbiamo detto possiamo avere diverse tipologie di cancro che si rendono evidenti in modo differente. Saperle riconoscere è di fondamentale importanza per capire come intervenire nel castagneto.
1 – Cancri normali
Vengono così definiti quelli causati da ceppi “virulenti” del patogeno. Si caratterizzano per la morte della parte del fusto o ramo sovrastante l’infezione, oltre alla produzione di rami epicormici alla base del cancro.
2 – Cancri anormali
Sono prodotti da ceppi ipovirulenti e si distinguono in cancri cicatrizzanti e cicatrizzati. Si differenziano dai precedenti per un evidente ingrossamento dell’area infetta, non portano a morte il fusto o ramo infetto, e non provocano l’emissione di rami epicormici. Il processo di cicatrizzazione costituisce la reazione della pianta all’infezione che espelle verso l’esterno gli strati di corteccia morta. La fase più avanzata di tale reazione produce i cancri completamente cicatrizzati (guariti). Spesso una evidente area nerastra indica l’avvenuta completa espulsione del micelio parassita.
3 – Cancri intermedi
Questi cancri presentano una sintomatologia intermedia tra i cancri normali e quelli anormali. Pur essendo presenti rami epicormici alla base del cancro, la parte superiore del fusto resta viva. Si osservano rigonfiamenti, arrossamenti, fessurazioni, e numerosi picnidi vengono prodotti anche in presenza di evidenti processi di cicatrizzazione. L’evoluzione di questi cancri è vincolata alla vitalità del fusto o ramo colpito: possono evolvere in cancri cicatrizzati se il fusto o ramo infetto è vigoroso, in caso contrario ne accelerano la morte.

Valutazione dei danni
La valutazione dell’impatto della malattia sui castagneti è di primaria importanza: occorre saper riconoscere i danni attuali da quelli verificatesi negli anni precedenti. E’ frequente osservare nei castagneti grosse branche secche completamente prive di corteccia, risultato di intensi attacchi risalenti a periodi anteriori e ancora sugli alberi per mancanza di potature. Esse conferiscono un aspetto degradato al popolamento e fanno sembrare gli attacchi di “C. parasitica” ben più gravi di quanto in realtà siano. Le infezioni attuali, invece, si riconoscono per la presenza di rami e rametti morti con ancora le foglie secche attaccate.
Lotta contro il cancro del castagno
Le osservazioni compiute ormai da decenni, in differenti comprensori forestali italiani ed europei, hanno messo in evidenza che la lotta contro il cancro del castagno può essere attuata favorendo il processo naturale della diffusione dei ceppi ipovirulenti per assicurare la sopravvivenza e la capacità produttiva dei castagneti. La principale azione da intraprendere a tale scopo è quella di eliminare fusti e rami uccisi dalla malattia, avendo cura di lasciare intatte le branche infette da cancri cicatrizzanti e cicatrizzati, come fonte di inoculo ipovirulento del patogeno.
In caso di gravi danni recenti è possibile procedere ad inoculazioni artificiali combinate con ceppi ipovirulenti selezionati. Tali interventi richiedono comunque una certa dose di competenze tecniche e di conoscenza della situazione ambientale.
La difesa degli innesti
Le ferite causate dagli innesti sono particolarmente suscettibili alle infezioni fungine. È in questo ambito che il cancro si dimostra particolarmente dannoso infatti, sia gli isolati virulenti che quelli ipovirulenti di “C. parasitica”, possono far fallire gli innesti.
Il consiglio del tecnico
Per quanto sopra riportato è molto importante che nell’innestare vengano scelti soggetti sani, e che si effettui il taglio con la massima precisione. Il punto di innesto deve essere protetto con mastici e si deve cercare di contenere lo sviluppo dei getti, al fine di evitare scosciamenti e lesioni che possono favorire gli attacchi del parassita. Occorre tenere presente che il patogeno infetta con minore facilità innesti eseguiti con tagli limitati. Pertanto sarebbero da preferire innesti su soggetti di piccole dimensioni, che prevedono ferite di ampiezza modesta, come quelli a spacco pieno, doppio spacco inglese o a gemma. •••
GLOSSARIO
Lotta biologica: è una tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi.
Parassitoide: insetto le cui larve si sviluppano all’interno del corpo di altri Artropodi o delle loro larve, nutrendosi delle loro carni fino alla metamorfosi, cioè mantenendolo in vita fino a che ne ha bisogno.
Predatore: in ambito di lotta biologica, così come avviene in natura, si intende un organismo che per sopravvivere deve cacciare altri organismi. La lotta biologica può essere effettuata cercando di favorire le presenze dei predatori allo stato selvatico, oppure, in loro mancanza, introducendoli artificialmente.
Picnidi: corpo fruttifero asessuato prodotto da funghi mitosporici; a maturità si apre facendo uscire le spore per la propagazione.
Ramo epicormico: ramo di più anni che si sviluppa sul fusto da una gemma dormiente.
BIBLIOGRAFIA
– Le principali malattie fungine del castagno, Addario-Turchetti (Istituto Protezione Piante, CNR)
– Il Castagno, Giancarlo Bounous, Edagricole
(tratto da CASENTINO2000 | n. 312 | Novembre 2019)