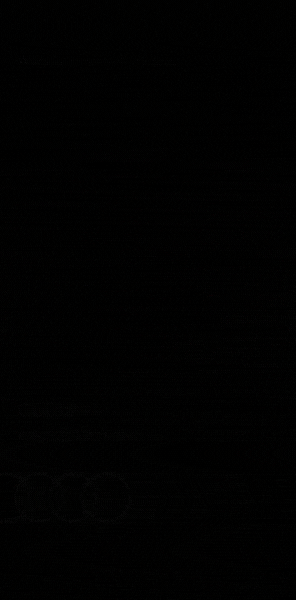di Carla Ciagli – Di notevole interesse è il lavoro che si svolgeva a Garliano, precisamente a Baribolle. Sembra che alle origini si denominasse Paripolle, considerando che l’abitato si trova a uguale distanza da due sorgenti o polle, una sovrastante e l’altra sottostante. Infatti la sorgente della Doccia dista dalle case quanto la fontanina del fosso. Solo Dio sa perché ai garlianesi sia rimasto più facile pronunciare la B piuttosto che la P, misteri morti e sepolti tra le mura e che ormai appartengono al passato.
Questo gruppo di case sorge su di un pianoro in prossimità del quale scorre l’omonimo torrente ricco di acqua limpida, a forte pendenza con accentuate variazioni di portata. Il nucleo abitativo è circondato da appezzamenti di terreno più o meno pianeggianti, graduati a terrazzamenti. Le culture predominanti erano: grano, patate e fagioli. Qua e là compare tutt’ora qualche filare di vite, alternato da alberi da frutto, peri, meli, noccioli e ciliegi. Il melo “nesto” produce frutti gustosi, facili da conservare, una volta raccolti e riposti nella paglia si mantengono fino a primavera.
Nelle serate d’inverno era abitudine andare a veglia nelle case dei vicini, le donne filavano la lana, oppure confezionavano con i ferri calze, solette e camiciole. Gli anziani, seduti sotto la cappa del camino raccontavano novelle, filastrocche e racconti paurosi di fochi fatui e di fantasmi visti nelle vicinanze del cimitero. Non c’era un luogo dove non si fosse visto o udito qualcosa di misterioso. I bambini sgranavano gli occhi e aprivano la bocca per l’attenzione, ma la paura era più forte della curiosità, stavano sempre più vicini gli uni agli altri, preoccupati per quando sarebbe arrivato il momento di andare a casa a dover affrontare il buio e i lugubri canti degli animali notturni.
Nel corso delle veglie venivano offerte: mele, brici (bruciate) e qualche bicchierotto di vinello, aspro e frizzante. Un’altra varietà di mela tipica dei nostri campi era: (la panaja) una qualità che va quasi scomparendo, di un bel rosso vivo, dalla forma leggermente piatta e dal sapore acidulo, per le sue caratteristiche ben si addiceva ad essere cotta in forno assumendo il nome di “boffolo”.
Agli inizi del novecento, la bottega dei Palarchi era una delle poche attività artigianali del paese, definirla “bottega” non era molto appropriato trattandosi di quattro mura seminterrate prive di una qualsiasi chiusura. All’interno di questo laboratorio venivano forgiate bullette dalle forme varie: a testa piatta e tonda, a punta di diamante o a borchia, chiodi da muratura, chiodi sfaccettati per la costruzione di scale. I Palarchi erano due fratelli, Vittorio e Giacinto. Giacinto, detto “Bandiera” era addetto alla ricerca del legname per bruciare nella forgia, utilizzava stecche di castagno, perché più adatte a mantenere il calore.
I bullettai non possedevano appezzamenti boschivi ed erano costretti a chiedere ai proprietari dei castagneti il permesso per poter prendere dalle vecchie ceppaie un po’ di legna morta. Severo, il fattore dei Bandini, autorizzava Giacinto a raccogliere nei boschi dei padroni ciò che gli serviva per poter svolgere quel modesto lavoro. Giacinto, per guadagnare qualche centesimo in più, tendeva vicino al pagliaio una rete, chiamata “paretaio” dentro alla quale rimanevano intrappolati i fringuelli, una volta catturati li accecava usando un ferro sottile a cui arroventava la punta, rinchiusi in piccole gabbie le povere bestiole venivano vendute ai cacciatori che li usavano come richiami. Vittorio era addetto alla forgia che alimentava attraverso un mantice a pedale. Il ferro una volta modellato veniva immerso in acqua mista ad olio, per migliorarne la tempra.
Chi passava sul poggetto della chiesa di Garliano sentiva il silenzio verde di quei monti rotto dal suono argentino e continuo del battere del martello rimbalzante sulla vecchia incudine. Raggiunto un certo quantitativo di bullette e chiodi, i nostri artigiani confezionavano tanti fagottini, dividendo per quantità e forma il materiale da distribuire ai vari calzolai e falegnami dislocati in tutto il Casentino. Per facilitarne il trasporto, visto che dovevano muoversi a piedi usavano un sacchetto di balla portato a spalla, con il peso dei chiodi ben distribuito; metà dietro la schiena e l’altra metà appoggiata sul petto. Nei giorni di mercato e di fiera, a Baribolle si poteva finalmente udire lo scrosciare delle due fonti, perché i martelli restavano in silenzio.
Per un giorno i vecchi artigiani cambiavano mestiere; erano là, sotto il portico di Poppi o di Bibbiena con il loro sacchetto di chiodi esposti, a tu per tu con ciabattini e falegnami, a cercare di vendere il loro prodotto al miglior prezzo e se al calar del sole, tornando verso casa con i sacchetti di chiodi vuoti e qualche palanca in tasca e un bicchiere di vino nella pancia, erano gente felice. Giacinto, rimase signorino, mentre Vittorio convolò a nozze con Modesta, che al paese tutti chiamavano “Mosca” in quanto non disdegnava un gotto di vino, spesso le capitava di ritrovarsi alticcia, amava anche annusare una presina di tabacco, che poi spargeva a suon di starnuti, stropicciandosi nelle maniche la gocciola scura che le colava dal naso.
A quei tempi, il miglior compagno della miseria era il vino (quando riuscivano ad averne) Vittorio, una sera mentre tornava a casa, scendendo lungo il viottolo che dalla chiesa portava a Baribolle essendo un po’ brillo finì per cascare dentro al fosso. Invocava a gran voce Giacinto perché gli venisse in aiuto. “Giacinto-Giacinto porta el mume”, che sarebbe poi stato il lume. Gli rispondeva il fratello: “ndo tu sei? dove sei? mondo ladro, to detto: porta el mume che son finito nel fosso”. Cosi, come altre volte si concludeva quella pietosa e grottesca comica. Vittorio, fradicio zuppo e traballante si aggrappava al fratello ed insieme se ne tornavano verso la misera dimora. La Mosca e Vittorio ebbero una figlia che chiamarono Rosina, che a sua volta andò in sposa ad un certo Piantini.
Nonostante che da questa unione fosse nata una bambina (Iride), le cose tra marito e moglie non andavano bene, il Piantini non aveva un lavoro fisso, quando gli capitava costruiva muri a secco per i terrazzamenti dei campi, spesso però si ritrovava a spasso. La povera Rosina, che dalla padella era finita nella brace, un giorno al colmo della disperazione e su richiesta di alcuni conoscenti fece fagotto e se ne andò a Roma a prendere servizio a casa di una signora, tenendo con sé la sua bambina. Scriveva regolarmente ai genitori e quando poteva gli inviava vestiario e viveri, ma in casa Palarchi erano analfabeti, perciò Vittorio si rivolgeva a Marta (figlia dei vicini) perché gli leggesse le notizie della figlia, ascoltava attentamente, poi al colmo della gioia diceva a Marta: hai sentito quel che ha detto la tata? (Rosina) Ha detto che sta bene e che manda i saluti.
Spesso era Marta che si prendeva l’incarico di acquistare per quei poveretti (alla bottega vicino alla chiesa, gestita da una zoppina di nome Gina) i pochi alimenti necessari per il vivere quotidiano: due acciughe involtate nella carta gialla, petrolio per il lume, pasta, zucchero e qualche spuntatura di sigaro. La mancia che Vittorio elargiva a Marta per questi servizi era di un ventino, pari a quattro soldi. Lentamente, con lo scorrere degli anni a Baribolle i martelli rimasero muti, la forgia spenta e l’incudine piena di ragnatele e polvere. Giacinto e Modesta, passarono a miglior vita a breve distanza uno dall’altro. Vittorio, stanco e solo non trovò più la forza per raccogliere un po’ di legna da bruciare nei rigidi inverni, fini così per staccare le assi dal pavimento della cucina e bruciarle nel camino.
La povera esistenza del bullettaio si concluse a Strada in Casentino, presso il ricovero dove era stato ospitato. Fu seppellito nel vicino cimitero della Pieve a Vado, sulla sua tomba la figlia Rosina fece innalzare una lapide imponente, alla rispettosa memoria di quest’umile artigiano che per più di mezzo secolo, tra l’incudine e il martello segnò la storia di Baribolle.
Sono passati tanti anni, Baribolle è ancora là su quel pianoro, alcune abitazioni sono state ristrutturate, ed è collegato al resto del paese attraverso una strada asfaltata. Ci sono nuove famiglie ed un’azienda agricola. Ai margini dello spiazzo, rivolta verso il fosso, irreale e fuori dal tempo quasi a voler sfidare le costruzioni moderne che la fiancheggiano, appare tuttora quasi integra la vecchia casa dei “Bullettai di Baribolle”.
Carla Ciagli (racconto tratto dal libro “Garliano in Casentino”, Pagnini Editore, 2021)